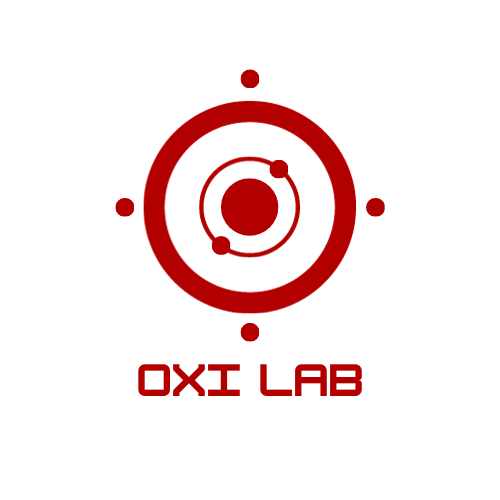Quali sono i principali disturbi tiroidei? Ipotiroidismo, ipertiroidismo, noduli e tiroiditi
Malattie della tiroide: sintomi, cause, diagnosi e cure di ipotiroidismo, ipertiroidismo, gozzo e noduli tiroidei
La tiroide è una piccola ghiandola a forma di farfalla situata nella parte anteriore del collo, ma svolge un ruolo fondamentale per la salute di tutto l’organismo. Produce infatti gli ormoni tiroidei, indispensabili per regolare il metabolismo, la crescita, lo sviluppo del sistema nervoso, la temperatura corporea e persino il benessere psicofisico.
Quando la tiroide non funziona correttamente, possono comparire diverse patologie tiroidee, che interessano milioni di persone in tutto il mondo e che colpiscono soprattutto le donne, con una frequenza fino a 10 volte superiore rispetto agli uomini. Queste condizioni spesso si manifestano in modo silenzioso o con sintomi aspecifici, come stanchezza, variazioni di peso o alterazioni dell’umore, rendendo la diagnosi non sempre immediata.
In questo articolo vedremo insieme le principali malattie della tiroide — dall’ipotiroidismo all’ipertiroidismo, dal gozzo ai noduli tiroidei — analizzandone cause, sintomi, esami diagnostici e trattamenti disponibili, per capire quando rivolgersi a uno specialista endocrinologo e come mantenere la salute della tiroide sotto controllo.
- La tiroide: una ghiandola piccola ma fondamentale
- Le malattie della tiroide
- Ipotiroidismo: cos’è e come si manifesta
- Ipotiroidismo: quali esami servono per la diagnosi
- Cause della tiroidite di Hashimoto
- Come si cura l’ipotiroidismo
- Ipertiroidismo: cos’è e come si manifesta
- Ipertiroidismo: esami utili per la diagnosi
- Come si cura l’ipertiroidismo
- Gozzo: cos’è, cause, sintomi e cure
- Noduli alla tiroide: cosa sono e quanto sono frequenti
- Noduli alla tiroide: esami per la diagnosi
- La prevenzione delle malattie della tiroide
- FAQ Endocrinologo: le risposte alle domande più frequenti

La tiroide: una ghiandola piccola ma fondamentale
La tiroide è una ghiandola endocrina situata nella parte anteriore del collo, davanti alla trachea. La sua funzione principale è quella di produrre gli ormoni tiroidei, sostanze indispensabili per il corretto funzionamento dell’organismo.
Gli ormoni tiroidei influenzano numerosi processi vitali:
- regolano il metabolismo e la produzione di energia;
- favoriscono la crescita corporea e lo sviluppo del sistema nervoso nel feto e nel bambino, garantendo un sano sviluppo psicofisico;
- contribuiscono al mantenimento della temperatura corporea;
- intervengono nel metabolismo lipidico e nel buon funzionamento del sistema cardiovascolare;
- influenzano il metabolismo basale e la regolarità del sonno.
Quando la tiroide non funziona correttamente, possono insorgere diverse
patologie tiroidee, che incidono sulla salute e sul benessere quotidiano.
Le malattie della tiroide
Le patologie tiroidee sono molto comuni nella popolazione generale e colpiscono soprattutto le donne, che ne sono interessate con una frequenza da 5 a 10 volte maggiore rispetto agli uomini. Negli ultimi anni, inoltre, si osserva un trend in crescita, anche a causa di una maggiore sensibilità diagnostica.
Uno degli aspetti più complessi è che queste malattie possono presentarsi senza sintomi evidenti o con disturbi aspecifici (stanchezza, variazioni di peso, nervosismo, alterazioni del sonno), rendendo la diagnosi meno immediata. Per questo motivo è fondamentale che il percorso inizi dal medico di base, che di fronte a un sospetto clinico può prescrivere i primi esami e, se necessario, indirizzare il paziente verso una visita specialistica endocrinologica.
Le malattie della tiroide possono derivare sia da un’alterazione della funzione della ghiandola (come nell’ipotiroidismo o nell’ipertiroidismo) sia dalla presenza di noduli tiroidei, ovvero formazioni che si sviluppano all’interno della ghiandola.
Nei prossimi paragrafi analizzeremo le principali patologie tiroidee:
cause, sintomi, esami diagnostici e possibili trattamenti, per aiutarti a riconoscerle e affrontarle con maggiore consapevolezza.
Visita Endocrinologica aVillafranca
Presso il nostro poliambulatorio Oxilab di Villafranca puoi effettuare una visita endocrinologica con il Prof. Moghetti, endocrinologo e diabetologo con una cattedra all'Univesità di Verona

Ipotiroidismo: cos’è e come si manifesta
L’ipotiroidismo è una condizione in cui la tiroide produce quantità insufficienti di ormoni tiroidei, causando un rallentamento dei processi metabolici dell’organismo. Nelle fasi iniziali può non dare sintomi evidenti, ma se non trattato può portare a conseguenze serie per la salute.
Cause dell’ipotiroidismo
Nella maggior parte dei casi, l’ipotiroidismo è acquisito e compare in età adulta. Le cause principali includono:
- carenza di iodio;
- tiroiditi autoimmuni, come la tiroidite di Hashimoto;
- assunzione di alcuni farmaci (ad es. litio in psichiatria, amiodarone per le aritmie cardiache);
- terapie con iodio radioattivo;
- asportazione chirurgica della tiroide (tiroidectomia);
- alterazioni della funzione dell’ipofisi, che attraverso l’ormone TSH regola l’attività tiroidea.
Esiste anche una forma congenita, presente dalla nascita, che può derivare da condizioni genetiche o da una grave carenza materna di iodio in gravidanza. L’ipotiroidismo congenito deve essere diagnosticato e trattato precocemente per evitare conseguenze irreversibili sullo sviluppo neurologico del bambino. Per questo in Italia è previsto lo screening neonatale obbligatorio della funzione tiroidea.
Sintomi dell’ipotiroidismo
L’ipotiroidismo acquisito inizialmente può essere asintomatico, ma con il tempo si manifesta con sintomi che variano in base a età, durata e gravità della malattia.
I sintomi più comuni sono:
- stanchezza e sonnolenza eccessive;
- aumento di peso;
- stipsi;
- rallentamento del battito cardiaco;
- pelle secca e pallida;
- intolleranza al freddo;
- voce rauca;
- difficoltà di memoria e concentrazione;
- eloquio rallentato;
- debolezza muscolare e crampi;
- colesterolo alto;
- ciclo mestruale irregolare;
- capelli fragili e sottili;
- gonfiore del volto e delle palpebre;
- umore depresso.
Nei casi più gravi può svilupparsi il mixedema, caratterizzato da accumulo di liquidi nei tessuti, gonfiore cutaneo e riduzione della funzione muscolare e cardiaca. La complicanza estrema è il coma mixedematoso, potenzialmente letale se non trattato.
L’ipotiroidismo congenito, invece, può manifestarsi con:
- difficoltà respiratorie;
- ittero;
- stipsi;
- problemi di suzione;
- lingua ingrossata;
- pianto rauco;
- difficoltà a mantenere il capo eretto o la posizione seduta;
- ritardo della maturazione ossea.
L’ipotiroidismo è una condizione in cui la tiroide produce quantità insufficienti di ormoni tiroidei, causando un rallentamento dei processi metabolici dell’organismo. Nelle fasi iniziali può non dare sintomi evidenti, ma se non trattato può portare a conseguenze serie per la salute.
Cause dell’ipotiroidismo
Nella maggior parte dei casi, l’ipotiroidismo è acquisito e compare in età adulta. Le cause principali includono:
- carenza di iodio;
- tiroiditi autoimmuni, come la tiroidite di Hashimoto;
- assunzione di alcuni farmaci (ad es. litio in psichiatria, amiodarone per le aritmie cardiache);
- terapie con iodio radioattivo;
- asportazione chirurgica della tiroide (tiroidectomia);
- alterazioni della funzione dell’ipofisi, che attraverso l’ormone TSH regola l’attività tiroidea.
Esiste anche una forma congenita, presente dalla nascita, che può derivare da condizioni genetiche o da una grave carenza materna di iodio in gravidanza. L’ipotiroidismo congenito deve essere diagnosticato e trattato precocemente per evitare conseguenze irreversibili sullo sviluppo neurologico del bambino. Per questo in Italia è previsto lo screening neonatale obbligatorio della funzione tiroidea.
Sintomi dell’ipotiroidismo
L’ipotiroidismo acquisito inizialmente può essere asintomatico, ma con il tempo si manifesta con sintomi che variano in base a età, durata e gravità della malattia.
I sintomi più comuni sono:
- stanchezza e sonnolenza eccessive;
- aumento di peso;
- stipsi;
- rallentamento del battito cardiaco;
- pelle secca e pallida;
- intolleranza al freddo;
- voce rauca;
- difficoltà di memoria e concentrazione;
- eloquio rallentato;
- debolezza muscolare e crampi;
- colesterolo alto;
- ciclo mestruale irregolare;
- capelli fragili e sottili;
- gonfiore del volto e delle palpebre;
- umore depresso.
Nei casi più gravi può svilupparsi il mixedema, caratterizzato da accumulo di liquidi nei tessuti, gonfiore cutaneo e riduzione della funzione muscolare e cardiaca. La complicanza estrema è il coma mixedematoso, potenzialmente letale se non trattato.
L’ipotiroidismo congenito, invece, può manifestarsi con:
- difficoltà respiratorie;
- ittero;
- stipsi;
- problemi di suzione;
- lingua ingrossata;
- pianto rauco;
- difficoltà a mantenere il capo eretto o la posizione seduta;
- ritardo della maturazione ossea.
Ipotiroidismo: quali esami servono per la diagnosi
La diagnosi di ipotiroidismo si basa principalmente su semplici esami del sangue, che permettono di valutare:
- i livelli di ormoni tiroidei (FT3 e FT4);
- i valori di TSH (ormone tireostimolante, prodotto dall’ipofisi per regolare la tiroide).
Un innalzamento del TSH associato a una riduzione degli ormoni tiroidei è il segnale tipico di ipotiroidismo.
In presenza di sospetto autoimmunità, il medico può prescrivere ulteriori accertamenti:
- il dosaggio degli anticorpi anti-tiroide (anti-tireoglobulina e anti-tireoperossidasi), utili per identificare malattie autoimmuni;
- l’ecografia tiroidea, che permette di studiare la struttura e l’aspetto della ghiandola.
La forma più frequente di ipotiroidismo è infatti di origine autoimmune ed è nota come
tiroidite di Hashimoto.

Hai sintomi riconducibili a un problema tiroideo? Rivolgiti ai nostri specialisti per una valutazione accurata della funzionalità tiroidea. Oxilab Ambulatori Villafranca offre analisi e visite dedicate per una diagnosi rapida e affidabile.
Prenota ora la tua consulenza in medicina specialistica.
Cause della tiroidite di Hashimoto
La tiroidite di Hashimoto è una malattia autoimmune: il sistema immunitario, invece di proteggere l’organismo, riconosce la tiroide come un tessuto estraneo e la attacca producendo anticorpi specifici. Nel tempo questo processo porta a una progressiva distruzione della ghiandola, che non è più in grado di produrre quantità adeguate di ormoni tiroidei.
Nonostante non sia una malattia ereditaria, esiste una predisposizione familiare: chi ha parenti con disturbi tiroidei ha un rischio maggiore di sviluppare la patologia. La tiroidite di Hashimoto può comparire a qualsiasi età, ma è molto più frequente nelle donne.
Sintomi della tiroidite di Hashimoto
In molti casi la malattia può restare silente per anni, senza sintomi evidenti. Quando la distruzione della ghiandola compromette in modo significativo la produzione di ormoni, compaiono i sintomi dell’ipotiroidismo: stanchezza, aumento di peso, intolleranza al freddo, pelle secca, capelli fragili, difficoltà di concentrazione, umore depresso.
In alcuni casi il processo è più rapido: la tiroide danneggiata rilascia improvvisamente nel sangue una grande quantità di ormoni immagazzinati, causando una condizione chiamata
tireotossicosi. Questa fase si manifesta con sintomi simili all’ipertiroidismo, come agitazione, tachicardia, perdita di peso e sudorazione eccessiva.
Come si cura l’ipotiroidismo
Il trattamento dell’ipotiroidismo si basa sulla terapia ormonale sostitutiva, che consiste nell’assunzione per via orale dell’ormone tiroideo mancante, la levotiroxina.
La terapia viene impostata in modo progressivo: di solito si inizia con dosaggi ridotti, che vengono aumentati gradualmente in base all’età, alla storia clinica e alla risposta individuale del paziente. In genere, il trattamento deve essere proseguito per tutta la vita, con controlli periodici per verificare che la dose sia sempre adeguata e mantenga i livelli ormonali entro valori ottimali.
È importante sapere che alcuni
cibi, farmaci e integratori possono ridurre l’assorbimento della levotiroxina. Tra questi:
soia, papaya, avena, integratori di ferro, calcio, colestiramina e idrossido di alluminio. Per questo motivo è fondamentale informare sempre il medico sulle proprie
abitudini alimentari e sull’eventuale assunzione di altri farmaci o integratori, così da impostare la terapia nel modo più efficace.
Ipertiroidismo: cos’è e come si manifesta
L’ipertiroidismo è una condizione in cui la tiroide produce un eccesso di ormoni tiroidei, con conseguente accelerazione dei processi metabolici dell’organismo. Questo squilibrio può avere ripercussioni su diversi apparati, in particolare sul cuore e sul metabolismo osseo, aumentando il rischio di complicanze se non trattato correttamente.
Cause dell’ipertiroidismo
Le principali cause dell’ipertiroidismo sono:
- Morbo di Basedow-Graves: malattia autoimmune nota anche come gozzo tossico diffuso, caratterizzata dall’aumento del volume della tiroide e dalla produzione eccessiva di ormoni;
- Noduli tiroidei: presenti in condizioni come il gozzo tossico multinodulare o l’adenoma tossico (malattia di Plummer), che stimolano una produzione autonoma di ormoni;
- Tiroiditi: infiammazioni della tiroide che determinano il rilascio nel sangue degli ormoni accumulati nella ghiandola;
- Farmaci: alcuni trattamenti, come interferone e amiodarone, possono interferire con la funzione tiroidea.
Sintomi dell’ipertiroidismo
L’ipertiroidismo può manifestarsi con una vasta gamma di sintomi, più o meno intensi in base alla gravità della malattia:
- perdita di peso improvvisa associata ad aumento dell’appetito;
- tachicardia, aritmie e palpitazioni;
- ansia, nervosismo, irritabilità, irrequietezza;
- tremori e sudorazione eccessiva;
- disturbi del ciclo mestruale;
- intolleranza al caldo;
- alterazioni intestinali (diarrea o alvo frequente);
- stanchezza e debolezza muscolare;
- insonnia o disturbi del sonno;
- pelle sottile e fragile, capelli indeboliti;
- oftalmopatia di Graves (esoftalmo, occhi sporgenti, tipici del morbo di Basedow);
- in caso di
tiroiditi subacute, possono comparire febbre e dolore al collo.
Ipertiroidismo: esami utili per la diagnosi
La diagnosi di ipertiroidismo richiede innanzitutto una visita endocrinologica specialistica, durante la quale il medico raccoglie un’anamnesi accurata, valuta la storia clinica del paziente e indaga la presenza di eventuali sintomi caratteristici. L’esame fisico può rivelare segni tipici come tachicardia, tremori, gozzo o esoftalmo.
Gli esami di laboratorio rappresentano lo strumento principale per confermare la diagnosi. In particolare vengono analizzati:
- i livelli di TSH, solitamente soppressi in caso di ipertiroidismo;
- i valori di FT3 e FT4, spesso elevati;
- la presenza di anticorpi tiroidei (anti-tireoglobulina, anti-tireoperossidasi e anticorpi anti-recettore del TSH), utili per identificare le forme autoimmuni come il morbo di Basedow-Graves.
A completamento della valutazione, lo specialista può prescrivere:
- un’ecografia tiroidea, per studiare la morfologia della ghiandola e rilevare eventuali noduli;
- una
scintigrafia tiroidea, utile a valutare la funzionalità dei noduli e distinguere tra forme diffuse e localizzate di ipertiroidismo.
Come si cura l’ipertiroidismo
Il trattamento dell’ipertiroidismo deve essere sempre personalizzato, in base alla causa scatenante, all’età del paziente, alla storia clinica e alla gravità dei sintomi.
- Morbo di Basedow-Graves → la prima scelta è la terapia farmacologica con farmaci antitiroidei. In caso di recidiva o mancata risposta, possono essere necessarie altre opzioni: terapia radiometabolica con iodio radioattivo o intervento chirurgico di tiroidectomia.
- Tiroiditi subacute → il trattamento di riferimento sono i cortisonici, per ridurre l’infiammazione e i sintomi correlati.
- Ipertiroidismo da noduli tiroidei o gozzo → la strategia dipende dal quadro clinico: si può optare per iodio radioattivo, chirurgia o tecniche di radiologia interventistica per ridurre il volume nodulare.
Oltre alle terapie specifiche, il medico fornisce anche indicazioni pratiche:
- limitare l’apporto di iodio, presente in alcuni alimenti (sale iodato, alghe, crostacei) e in integratori o farmaci che non vanno assunti senza controllo medico;
- monitorare vitamina D e calcio, perché l’ipertiroidismo non trattato a lungo può favorire osteopenia e osteoporosi.
- Grazie a un percorso diagnostico e terapeutico accurato, l’ipertiroidismo può essere gestito efficacemente, riducendo i sintomi e prevenendo le complicanze.
Gozzo: cos’è, cause, sintomi e cure
Il gozzo è un ingrossamento della tiroide, ovvero un aumento del volume della ghiandola, che può presentarsi in forma lieve o più marcata.
Cause del gozzo
La causa più frequente del gozzo è la
carenza di iodio, condizione che in Italia ha carattere endemico in alcune aree (si parla infatti di endemia gozzigena).
Anche l’assunzione in quantità eccessive di alcuni alimenti detti
gozzigeni (come cavoli, cavolfiori e altre verdure appartenenti alla famiglia delle brassicacee) può favorire l’aumento di volume della tiroide.
Sintomi del gozzo
Un gozzo di
piccole dimensioni può non dare sintomi evidenti.
Quando però l’ingrossamento diventa più marcato, la pressione esercitata su
trachea ed
esofago può provocare:
- difficoltà respiratorie;
- difficoltà nella deglutizione;
- sensazione di “nodo in gola”.
Cura del gozzo
Il trattamento del gozzo dipende dalla sua grandezza e dalla sintomatologia:
- per gozzi di piccole o medie dimensioni, lo specialista può indicare la terapia radiometabolica con iodio radioattivo;
- nei gozzi di grandi dimensioni, la scelta più comune è l’intervento chirurgico di asportazione parziale o totale della tiroide (tiroidectomia).
- La valutazione e la scelta terapeutica devono sempre essere personalizzate in base al quadro clinico del paziente.
Noduli alla tiroide: cosa sono e quanto sono frequenti
I noduli tiroidei sono formazioni solide che si sviluppano all’interno della ghiandola tiroidea. Nella maggior parte dei casi sono benigni: solo il 3-5% presenta caratteristiche maligne.
Secondo l’Istituto Superiore di Sanità, i noduli sono la condizione tiroidea più diffusa. Dopo i 50 anni, infatti, oltre il 30-40% della popolazione presenta almeno un nodulo rilevabile con l’ecografia.
Cause dei noduli alla tiroide
La principale causa della formazione di noduli tiroidei è la
carenza di iodio.
In rari casi, un’alimentazione basata quasi esclusivamente su cavoli, cavolfiori e altre brassicacee (alimenti detti gozzigeni) può favorirne lo sviluppo, anche se si tratta di una condizione poco frequente con le abitudini alimentari comuni.
Una piccola percentuale di noduli (3-5%) è di origine maligna: si tratta di tumori tiroidei che generalmente hanno crescita lenta e sono poco aggressivi, ma richiedono comunque una diagnosi precoce e un adeguato trattamento.
Sintomi dei noduli alla tiroide
Nella maggior parte dei casi, i noduli tiroidei sono asintomatici e vengono scoperti in modo casuale durante esami eseguiti per altri motivi. Per questo motivo sono spesso definiti “incidentalomi”.
Quando presenti, i sintomi più comuni sono:
- difficoltà nella deglutizione;
- difficoltà respiratorie;
- sensazione di pressione o costrizione al collo.
- In alcuni casi, i noduli possono diventare
funzionanti, cioè produrre un eccesso di ormoni tiroidei e determinare un quadro di
ipertiroidismo. In questa situazione si manifestano sintomi come
tachicardia, perdita di peso, aumento dell’appetito e nervosismo.
Noduli alla tiroide: esami per la diagnosi
Circa il 5-10% dei noduli tiroidei può essere diagnosticato già con una semplice visita clinica, attraverso l’ispezione e la palpazione del collo.
Negli ultimi anni, grazie alle tecnologie più moderne, in particolare l’ecografia tiroidea, è stato possibile individuare un numero sempre maggiore di noduli, anche di dimensioni molto piccole, che non sarebbero rilevabili con la sola palpazione. Tuttavia, la maggior parte dei noduli rilevati con l’ecografia non ha rilevanza clinica: per questo motivo, l’esame non va eseguito come strumento di screening di massa, ma solo in presenza di sospetto clinico o alterazioni degli esami del sangue.
L’ecografia tiroidea consente di analizzare caratteristiche fondamentali dei noduli (dimensioni, forma, margini, vascolarizzazione) e, in base a questi parametri, lo specialista endocrinologo può valutare il rischio di malignità.
Se il nodulo presenta caratteristiche sospette, il medico può prescrivere un ulteriore approfondimento: l’agoaspirato tiroideo, un prelievo di cellule dal nodulo che vengono poi analizzate al microscopio con esame citologico, utile per distinguere tra noduli benigni e maligni.

Ecografia tiroidea e valutazione specialistica in un’unica sede
Presso Oxilab è possibile eseguire
ecografia tiroidea, esami del sangue e
visita endocrinologica nello stesso percorso, con risultati rapidi e referti chiari.
Scopri il servizio nel nostro centro di Oxilab Ambulatori Villafranca
Noduli alla tiroide: come si curano
Il trattamento dei noduli tiroidei dipende dalla loro natura, dalle dimensioni e dalla presenza o meno di sintomi.
- Noduli benigni, piccoli e non funzionanti
In assenza di sintomi, è sufficiente un monitoraggio ecografico periodico, senza necessità di interventi immediati. - Noduli benigni di dimensioni maggiori
Se provocano sintomi come disfonia (voce alterata), disfagia (difficoltà a deglutire) o segni di compressione/ deviazionetracheale, lo specialista può valutare la necessità di un intervento chirurgico o di altre terapie locali. - Noduli iperfunzionanti
Si tratta di noduli benigni che producono un eccesso di ormoni tiroidei, causando ipertiroidismo. In questi casi il trattamento prevede la chirurgia o la terapia radiometabolica con iodio radioattivo. - Noduli sospetti per malignità
In presenza di caratteristiche ecografiche o citologiche sospette, può essere indicata l’asportazione chirurgica parziale o totale della tiroide. La strategia viene sempre personalizzata in base al rischio individuale: nei casi a prognosi favorevole si opta per interventi meno invasivi, mentre nelle forme più aggressive si associa la chirurgia alla terapia radiometabolica.
Nel 90% dei casi la chirurgia porta a una guarigione definitiva.
La prevenzione delle malattie della tiroide
Anche se non ci sono delle misure specifiche che possono essere adottate per prevenire le condizioni tiroidee, una carenza di iodio è spesso alla base dell’insorgenza di alcune di esse. Quindi, può essere utile, con l’aiuto di un medico o nutrizionista, correggere la propria alimentazione in modo da apportare una giusta quantità di questo elemento, ad esempio, tramite un maggiore consumo di pesce e l’uso di sale iodato. Ricordiamo che lo iodio si scioglie in acqua e non è presente nell’aria di mare, contrariamente a quanto talvolta popolarmente ritenuto.
Le malattie della tiroide nelle donne
Esiste uno stretto legame tra patologia tiroidea e genere femminile, essendo tali condizioni largamente prevalenti nelle donne rispetto agli uomini.
Se dal punto di vista sintomatologico, le manifestazioni cliniche sono simili nei due generi, nelle donne è necessaria una valutazione più attenta della funzione tiroidea in relazione alla ricerca di gravidanza.
Le malattie della tiroide possono, infatti, avere ripercussioni negative sulla fertilità femminile e su un’eventuale gravidanza: possono, per esempio, influire sulla regolarità mestruale, aumentare le probabilità di un aborto spontaneo e impedire il corretto sviluppo del feto.
Per tale ragione, prima o durante la gravidanza è raccomandato eseguire le appropiate indagini di funzione tiroidea per assicurarsi che questa sia ottimale. Inoltre, può essere utile sapere che eventuali malattie autoimmuni tiroidee possono attenuarsi notevolmente durante la gravidanza in virtù di una maggiore tolleranza immunitaria, tornando, però, a manifestarsi dopo il parto.
Endocrinologo a Villafranca
Presso gli Ambulatori Oxilab di Villafranca il Prof. Moghetti, esegue visite endocrinologiche e diabetologiche complete e di controllo.
Prenota ora la tua visita con il Prof. Moghetti

FAQ Endocrinologo: le risposte alle domande più frequenti
I
noduli alla tiroide sono una condizione molto diffusa, ma spesso creano dubbi e preoccupazioni: sono sempre pericolosi? Come si diagnosticano? È necessario operare subito? Per fare chiarezza, ecco le
risposte alle domande più frequenti che i pazienti pongono sull’argomento.
I noduli alla tiroide sono sempre maligni?
No. La grande maggioranza dei noduli tiroidei è benigna. Solo una piccola percentuale (circa il 3-5%) è di natura maligna, ma grazie a esami mirati è possibile distinguere i casi che richiedono un trattamento specifico.
Come si scopre di avere noduli alla tiroide?
Spesso i noduli vengono scoperti per caso, durante esami effettuati per altri motivi. In alcuni casi, però, possono causare disturbi respiratori, difficoltà a deglutire o sensazione di pressione al collo.
Quali esami servono per la diagnosi?
Il primo passo è la visita endocrinologica con palpazione del collo. L’ecografia tiroidea consente di valutare le caratteristiche dei noduli e, se necessario, l’endocrinologo può prescrivere un agoaspirato per analizzarne le cellule al microscopio.
Quando è necessario operare un nodulo alla tiroide?
Non tutti i noduli devono essere rimossi. In caso di noduli benigni e piccoli, è sufficiente un monitoraggio ecografico periodico. Se invece causano sintomi compressivi, sono iperfunzionanti o presentano caratteristiche sospette, lo specialista può valutare l’intervento chirurgico.
I noduli tiroidei causano sempre sintomi?
No. Molti noduli sono asintomatici. Quando presenti, i sintomi più comuni sono difficoltà di deglutizione, problemi respiratori o senso di costrizione al collo. In rari casi i noduli funzionanti possono dare segni di ipertiroidismo (tachicardia, perdita di peso, ansia).
Presso gli Ambulatori Oxilab di Villafranca, il Prof. Paolo Moghetti, endocrinologo, mette a disposizione la sua competenza ed esperienza per offrire ai pazienti un percorso di prevenzione, diagnosi e cura altamente qualificato.
Prenota la tua visita
endocrinologica con il Prof. Moghetti: online, via WhatsApp o telefonicamente. La salute ormonale è alla base del tuo benessere.